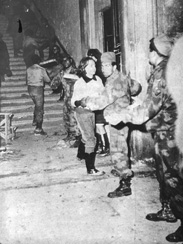home » Il disastro » I primi interventi
I primi interventi
“Si informa che sin dal giorno 8 u.s. è stata iniziata una recognizione degli archivi esistenti nella Città e sottoposti alla vigilanza; in tale occasione è stata presa visione anche di archivi non vigilati. Il numero degli archivi di cui è stata fatta una recognizione non è per ora rilevante per la difficoltà sempre crescenti del transito per strade in cui sono ammassati detriti gettati fuori dai negozi e dalle case e per il fatto che nella maggior parte delle strade si può solo camminare a piedi a causa delle macchine e dei camions che ammucchiano e portano via tali detriti”Con queste parole, contenute in una relazione del 13 novembre 1966, il soprintendente Giulio Prunai riferiva al Ministero dell’Interno che fin dall’8 novembre la Soprintendenza aveva fatto partire l’indispensabile operazione di ricognizione e censimento degli archivi, estesa anche agli archivi non vigilati, e di cui in alcuni casi si ignorava precedentemente perfino l’esistenza. Ma non nascondeva l’enorme difficoltà dell’impresa, sia a Firenze che nel resto della Toscana.
Come scriverà nell’articolo pubblicato su Antichità viva del 1966.
In teoria la strada da seguire era la seguente: censimento degli archivi, dei danni e delle distruzioni, recupero del materiale archivistico, trattamento dei documenti ai fini della essicazione, della disinfestazione, della distruzione di muffe e, infine, l’impiego di tecnici per lo svolgimento dell’opera di restauro da intendersi nel modo più ampio e duraturo.
Ma la teoria doveva fare i conti con la realtà. Seguiamo ancora il racconto di Prunai:
Il censimento […] e la determinazione dei danni subiti non furono né semplici né rapidi sia per le difficoltà di comunicazione con i vari centri della nostra Regione, sia per la mancanza di mezzi di trasporto e, occorre confessarlo, per la indecisione del primo momento sui mezzi da adottare e sulla condotta da tenere per salvare quanto più materiale possibile e per far fronte, con due soli funzionari, a occorrenze molteplici e diverse situazioni prodottesi in località distanti tra di loro. Mentre alcuni archivi fiorentini poterono essere subito visitati e di altri si poté avere notizia indiretta, quelli di altre località della Provincia e della Regione furono raggiunti solo in proseguo di tempo usufruendo di una campagnola della polizia e, soprattutto, di aiuto e offerte da privati.
Le azioni successive, quelle del recupero del materiale danneggiato e della sua asciugatura vennero eseguite, spesso con personale volontario e con l’aiuto degli stessi proprietari degli archivi alluvionati, in fasi diverse: prima attraverso il trasferimento degli archivi in depositi asciutti fin dai giorni immediatamente successivi all’alluvione (e ciò fu possibile grazie alla collaborazione con l’Archivio di Stato, i militari, i Vigili del Fuoco e i numerosi volontari), poi con operazioni successive di interfoliazione, eseguite dove era possibile. Dopo l’ interfoliazione, che si rivelò comunque insufficiente anche se ripetuta fino a cinque volte, i documenti furono smistati ini vari centri di raccolta in particolare a Cortona, Prato, Perugia, e soprattutto a San Giustino Umbro, dove i forni del Consorzio dei tabacchicultori vennero utilizzati per l’essicazione delle carte.
Nella sua azione di tutela e salvaguardia, la Soprintendenza Archivistica si trovò spesso a dover travalicare i limiti delle sue funzioni di controllo, soprattutto nei confronti dei privati, come testimonia Augusto Antoniella, funzionario della Soprintendenza Archivistica, nel suo articolo Pubblicazioni sull’alluvione del 4 novembre 1966:
la Soprintendenza, di fronte alla sicura rovina cui andavano incontro alcuni archivi sottoposti alla vigilanza dell’ufficio, fu costretta ad andare oltre il limite delle sue funzioni di controllo, intervenendo in sostituzione dei privati proprietari di carte, a recuperare i materiali e convogliarli, con mezzi di volta in volta reperiti, nei centri appositi, quando non era possibile provvedere ad essi nelle rispettive sedi. Si deve certamente a questa iniziativa se molti archivi privati non hanno subito danni ben più gravi durante quei giorni di scompiglio [..] e se oggi sono curati con la stessa attenzione usata per quelli di competenza dello Stato.
Si può affermare che da quei tragici giorni prenda le mosse uno stile di lavoro e un rapporto fortemente collaborativo con i proprietari di archivi, che ha sempre caratterizzato anche successivamente la Soprintendenza toscana.
Queste operazioni richiesero un impegno finanziario molto superiore ai fondi inizialmente disponibili. Fondamentale fu l’aiuto, in termini di fondi e di persone, proveniente da molti privati e da associazioni appositamente costituitesi, come il Comitato del Fondo Internazionale, l’Italian Art and Archieves Rescue di Londra, e l’americano Committee to Rescue Italian Art (CRIA), che contribuirono in modo sostanziale al recupero e al riconoscimento del materiale danneggiato dall’alluvione.
La Soprintendenza Archivistica diffuse inoltre un documento con le direttive per il Recupero e conservazione del materiale archivistico alluvionato e fornì mezzi per il trattamento della documentazione danneggiata a molti enti pubblici e a privati.